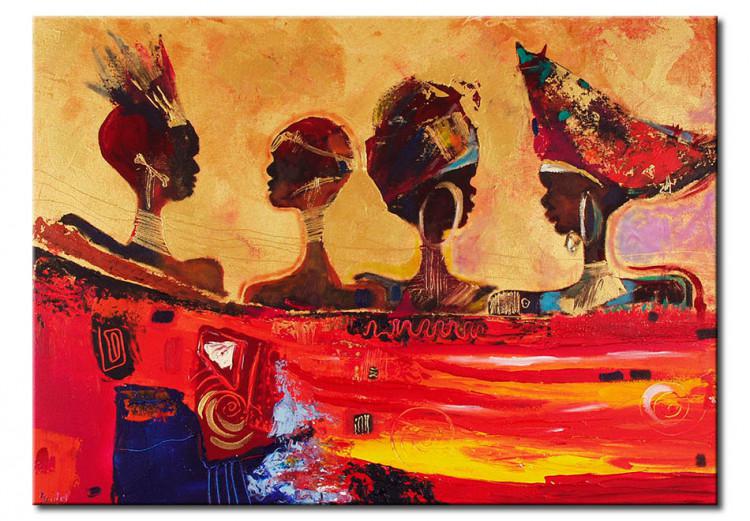
L’importanza dell’essere visti
Essere visti rappresenta il nostro certificato di esistenza, il riconoscimento del nostro posto nella società e il riflesso della nostra identità attraverso gli occhi degli altri. Questo bisogno, probabilmente presente anche nei nostri antenati, dai Neanderthal ai primati, si manifesta come una dinamica fondamentale nelle relazioni umane. L’interazione con gli altri è essenziale per formare la nostra “imago interna”, l’immagine che costruiamo di noi stessi sulla base delle percezioni altrui.
La relazione con i “tu certificatori” — coloro che validano la nostra esistenza — varia in intensità. Più una relazione è intima, più il riconoscimento dell’altro assume un’importanza vitale. Essere visti da persone care come genitori, amici, partner o figli costituisce un pilastro fondamentale della nostra autostima. Allo stesso modo, l’approvazione dei colleghi, degli insegnanti o dei superiori contribuisce al nostro senso di appartenenza sociale.
Esempio di mappa dei "tu certificatori"

La fragilità dell’imago interna
In epoca pre-social, era possibile disegnare una vera e propria mappa dei “tu certificatori” di ognuno, con i diversi livelli di importanza, e la nostra “imago interna” si formava attraverso una complessa interazione tra le percezioni altrui e il modo in cui le elaboravamo. Era possibile anche modificare questi livelli, il riconoscimento di alcune persone, magari anche solo in alcuni contesti, poteva assumere maggior valore o, al contrario, era possibile anche eliminare del tutto, dalla nostra “mappa dei tu”, persone non ritenute più degne di farvi parte. Quando invece si basa principalmente su un’autopercezione influenzata da fattori quantitativi, come il numero di follower o di like, anziché sulla qualità delle relazioni significative, questa immagine si indebolisce poiché non esiste più una discriminante che definisca l’importanza delle singole presenze della nostra vita: un “amico” è uguale all’altro e conta uno. Una certificazione dell’io costruita su metriche superficiali tende a essere instabile, poiché manca della profondità necessaria per sostenere un senso di identità autentico. In questo quadro, le poche presenze autentiche finiscono per acquisire un’importanza abnorme rispetto al pallore inconsistente dell’irrealistico quorum numerico generale, ciò può generare insicurezze profonde, creando una dipendenza affettiva patologica dovuta a una validazione esterna effimera e inautentica.
I social media, con la loro enfasi sui numeri, hanno amplificato questa fragilità. La quantità di interazioni digitali spesso sostituisce la qualità delle relazioni personali, portando a un’inflazione del valore del riconoscimento. Questo fenomeno può distorcere la percezione del proprio valore personale, rendendo difficile distinguere tra un riconoscimento reale e uno superficiale.
L’impatto dei social media
L’era dei social media ha quindi trasformato profondamente il modo in cui percepiamo il riconoscimento e l’apprezzamento. Prima dell’avvento di queste piattaforme, i concetti di amicizia e ammirazione erano più profondi e radicati. Gli amici erano pochi e selezionati, e la loro influenza sulla nostra immagine interna era significativa. I social media, invece, hanno introdotto una dimensione numerica alle relazioni, trasformando “l'amico” in un semplice contatto virtuale e dando origine al fenomeno dei follower, una relazione unidirezionale simile a quella tra celebrità e ammiratori, generando così anche una forma piuttosto diffusa di megalomania che caratterizza un’estrema sopravvalutazione della propria importanza, tale da stimolare la nascita di agenzie che letteralmente costruiscono follower fittizi. Ciò, che può avere un significato pratico/economico (pur eticamente discutibile) quando si tratta realmente di chi fa dei loro contenuti social un lavoro, assume un connotato assai disfunzionale quando si tratta di semplici utenti.
Questa inflazione dei concetti di amicizia e ammirazione ha avuto conseguenze significative. La validazione, che un tempo era qualitativa e basata su interazioni significative, è diventata quantitativa, legata al numero di like e follower. Tuttavia, questa forma di riconoscimento è spesso effimera e manca della profondità necessaria per costruire un’immagine interna solida. Questo fenomeno può generare disfunzioni psicologiche, alimentando insicurezze, dipendenze affettive e, in alcuni casi, vere e proprie patologie.
Le conseguenze nelle relazioni
La distorsione dei meccanismi di riconoscimento ha avuto un impatto profondo sulle relazioni personali. L’assenza di relazioni vere, concrete e la conseguente immagine di Sé autocostruita, sono le basi per l’incipienza di una forma di narcisismo che crea, nel tempo, l’illusione di un Io bastevole, grandioso, che non necessita di nessuno, ma che nella realtà si aggrappa con unghie e denti a quei pochi riscontri concreti e reali: un Io inconsistente, evanescente e dipendente. La dipendenza affettiva, alimentata dalla necessità di essere visti e validati, può portare a dinamiche malsane. In alcune situazioni estreme questa dipendenza si manifesta in forme tragiche, come nei casi di violenza domestica o femminicidio.
Il femminicidio, spesso legato a una dinamica di possesso e controllo, rappresenta l’esito più estremo di una dipendenza affettiva patologica. In un contesto socio-emotivo come quello attuale dove le presenze reali e affettivamente nutrienti sono troppo poche per creare un’immagine di Sé stabile e consolidata, il rischio di perderne una si rivela intollerabile per il mantenimento della propria autostima, che non è sostenuta da altre persone. Così la rottura di una relazione viene percepita come una minaccia alla propria esistenza psicologica, l’assenza di riconoscimento può diventare insopportabile. Questo bisogno esasperato di certificazione dell’Io può sfociare in comportamenti distruttivi, compresa la violenza letale, auto o eterodiretta. Il femminicidio è l’apice dell’escalation: con l’omicidio l’assassino crea un fermo immagine di quella che è per lui l’unica possibile certificazione del suo Io, l’unica realmente in grado di rimandargli l’immagine di Sé sulla quale tutta la sua imago interna e la sua autostima si reggono: quella certificazione, con la rottura della relazione, sparirebbe definitivamente, disciogliendosi nel tempo e nello spazio. Allora l’assassino, nell’uccidere, perpetua quell’immagine, congela quel riconoscimento, quel “io ti vedo, sei importante per me” e, con quel gesto, diventa inevitabilmente la persona più importante della vita della sua vittima. Importante come la madre, che le ha dato la vita, si sente lui che glie la toglie. Nella sua mente, distorta e criminale, nulla potrà mai cambiare questo fatto: nessun ergastolo, nessuna fiaccolata, nessun dibattito televisivo. Lui è il risultato corrotto di un processo dove si costruisce un elemento gigantesco e complesso, come l’immagine interiore del Sé, senza le fondamenta che possano renderlo stabile e duraturo. Tentare il recupero della persona, replicando e rimodulando il suo iter evolutivo in modo da creare elementi reali e concreti di sostegno del Sé, ammesso sia possibile, sarebbe un lavoro lungo e quanto mai difficile, del quale probabilmente non si riuscirà nemmeno mai a valutare effettivamente il ritorno positivo.
Il filosofo Martin Buber sosteneva che il rapporto Io-Tu-l’altro diventa reale solo se viene percepito come un essere completo, nella sua interezza. Questa frase evidenzia come il riconoscimento reciproco sia alla base delle relazioni autentiche. Tuttavia, la società contemporanea rischia di ridurre questa profondità, trasformando l’Io-Tu in una mera connessione superficiale, proprio perché mancante di quella interezza che un numero di amici o follower non può fornire.
Inoltre, lo psicoanalista Donald Winnicott sottolineava l’importanza dello sguardo materno nello sviluppo dell’identità del bambino: “Il bambino esiste quando viene visto e rispecchiato dal volto della madre”1 Questa dinamica primordiale resta centrale anche nelle relazioni adulte, dimostrando quanto sia fondamentale il riconoscimento autentico per la costruzione di un’identità stabile.
Essere visti non è solo un bisogno, ma un elemento costitutivo della nostra identità. La società moderna, con le sue trasformazioni tecnologiche e culturali, deve affrontare la sfida di riscoprire il valore autentico delle relazioni umane. Solo attraverso un riconoscimento sincero e profondo possiamo costruire un mondo in cui l’essere visti non sia una necessità disperata, ma una celebrazione della nostra esistenza. La tecnologia, che porta verso una presenza sempre più consistente dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite, dovrebbe analizzare e far tesoro delle conseguenze psico-sociologiche sin qui sperimentate, per poter fornire a politica e industria i giusti parametri entro i quali poter agire nella visione di un futuro nel quale sia l’uomo ad utilizzare e condizionare la tecnologia anziché il contrario.
Fonti bibliografiche e citazioni
[1] Donald Winnicott, Il ruolo dello specchio della madre e della famiglia nello sviluppo del bambino in Sviluppo affettivo e ambiente, 1965
Carl Rogers – On becoming a Person, 1961
“Essere profondamente ascoltati da un’altra persona è un dono raro e prezioso che ci aiuta a vedere e accettare noi stessi”.
Martin Buber – Io e tu, 1923
“L’io diventa io nel suo rapporto con il Tu; diventa io proprio nell’atto stesso del rapporto”.
George Albert Mead – Mind, Self, and Society, 1934
“Il sé non è qualcosa con cui si nasce; si sviluppa attraverso il processo di interazione sociale”.
Maurice Merlau-Ponty – Fenomenologia della percezione, 1945
“Il corpo e la percezione dell’altro sono centrali per l’esperienza dell’Io”.
